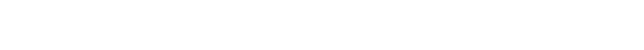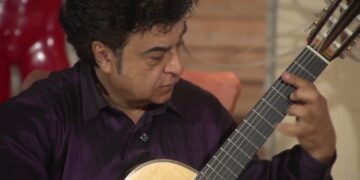Ogni 6 maggio si celebra in Vaticano, nel cortile di San Damaso, il giuramento della Guardia Svizzera, ricorrenza che testimonia l’atto di eroismo più fulgido di questo speciale corpo militare tra i più antichi al mondo.
Il 6 maggio 1527 le milizie del Contestabile di Borbone occuparono Roma ed attuarono quello che viene ricordato come il “sacco di Roma”. Anche i Palazzi Apostolici furono messi a ferro e fuoco, tuttavia, la strenua resistenza degli “Svizzeri” – è questo il nome che, affettuosamente, il popolo di Roma ha dato, sul filo dei secoli, alla guardia pontificia – permise a Clemente VII di lasciare il Vaticano, attraverso il corridoio segreto costruito da Alessandro VI, e di rifugiarsi a Castel Sant’Angelo. Morirono 147 guardie, se ne salvarono solo 42, coloro che avevano accompagnato il Papa al Castello.
Il Gregorovius nella “Storia di Roma nel Medioevo” descrive così quella catastrofe: «Quando spuntò l’alba del 7 maggio lo spettacolo che Roma offriva di sé era più orribile quanto si possa immaginare: le strade ingombre di rovine, di cadaveri e di moribondi; case e chiese divorate dal fuoco dalle quali uscivano grida e lamenti; un orribile trambusto di gente che rubava e che fuggiva; Lanzichenecchi ubriachi, carichi di bottino o che si trascinavano dietro prigionieri. Diritto di guerra a quel tempo significava licenza di saccheggiare una città conquistata ma anche facoltà di considerare tutta la popolazione vinta niente altro che carne da macello.
Nessun Lanzichenecco avrebbe capito che era disumano trattare dei cittadini inermi come degli schiavi di guerra. Chi aveva cara la vita doveva riscattarla. Niente e nessuno fu risparmiato. Le case dei romani furono saccheggiate. In molti palazzi si erano rifugiate persone di ogni ceto, a centinaia; gli spagnoli vi irruppero depredando e incendiando».
Fu un Papa celebre, Giulio II, che volle fondare un corpo armato addetto alla guardia del Pontefice: nel 1506 un reparto di 150 guardie svizzere, tutte provenienti dal Cantone di Zurigo, al comando di Kaspar von Silenen del Cantone di Uri, fece il suo ingresso in Vaticano entrando dalla Porta del Popolo. Anche dopo la fine del potere temporale dei Papi, nel 1870, gli “Svizzeri” continuarono la loro opera a fianco del Pontefice romano, sia pure con compiti diversi: oggi prestano Servizio d’Onore, di controllo e ordine, montano la guardia agli ingressi del Palazzo Apostolico, nei cortili di San Damaso e del Belvedere, nei piani delle varie Logge, nella Sala Regia, davanti agli uffici della Segreteria di Stato, nell’appartamento privato del Papa, agli ingressi esterni. Inoltre, sono impegnati quando il Santo Padre è presente nelle celebrazioni liturgiche in San Pietro, nelle Udienze Generali, nelle visite dei Capi di Stato, di Governo, Ministri degli Esteri e Ambasciatori.
Richiamando alla mente i fasti rinascimentali con gli squilli di tromba, il garrire degli stendardi, la ferrea disciplina militare, il fulgore delle alabarde, il fasto delle uniformi rosse con fluttuanti losanghe gialle e blu ed un elmo del XVI secolo di foggia spagnola appiattito ai lati e sormontato dalle piume di struzzo, con gorgiera, corazza e alabarda di due metri – che si vuole siano state disegnate da Michelangelo – la particolare suggestione rievocata dalla cerimonia del 6 maggio si colloca saldamente anche nei tempi moderni: il giuramento avviene difatti davanti agli sguardi fieri dei famigliari del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, oltre ad un gran numero di invitati, e sotto un tempestare di flash di fotografi.
La ricorrenza di quest’anno ha avuto un significato particolare: ha avuto luogo eccezionalmente sabato 4 ottobre 2025 e non nel tradizionale 6 maggio, a causa del rinvio dovuto alla morte di Bergoglio. La cerimonia si è svolta alla presenza di Papa Leone XIV, che ha presenziato per la prima volta dal 1968. Così, davanti a S.S. Leone XIV e ad un folto gruppo di Cardinali e Vescovi, il prelato officiante ha ricordato la necessità che, in un mondo sempre più inquinato da una polluzione che avvelena il cuore e lo spirito, sempre più vittima di quella che San Giovanni Paolo II definiva la “cultura della morte”, le guardie abbiano cura della loro spiritualità, vivano con gioia il messaggio del Vangelo, si disintossichino spiritualmente “incontrando il Signore”.
Ai discorsi ha fatto seguito la formula del giuramento delle nuove reclute, semplice e toccante – pronunciata secondo la lingua de Cantone di provenienza – con la mano destra levata e le tre dita aperte, a simboleggiare la Santissima Trinità, tenendo stretta nella sinistra la bandiera della Guardia: «Giuro di servire fedelmente, lealmente e onorevolmente il Sommo Pontefice Leone XIV e i suoi legittimi successori, come pure di dedicarmi a loro con tutte le forze, sacrificando, ove occorra, anche la vita per la loro difesa. Assumo del pari questi impegni riguardo al Sacro Collegio dei Cardinali per la durata della sede vacante. Prometto, inoltre, al Capitano Comandante e agli altri miei superiori rispetto, fedeltà e ubbidienza. Lo giuro. Che Iddio e i nostri Santi Patroni mi assistano».
È un giuramento che risale quasi alle origini, come la bandiera a colori blu, giallo e rosso, spartiti dalla croce bianca. Nel settore interno di sinistra campeggia l’arme di casa della Rovere alla quale apparteneva Giulio II, il settore superiore di destra è riservato allo stemma del Papa regnante mentre sulla croce bianca, al centro dello scudetto, spicca l’arme del comandante in carica.
«Lo spirito della Guardia Svizzera si nutre della gloriosa tradizione di quasi cinque secoli di storia: un piccolo esercito dai grandi ideali». Ricordo che così si era espresso Benedetto XVI, ricevendo nella Sala Clementina le nuove reclute: «(…) grazie al vostro servizio le cerimonie liturgiche e i numerosi incontri si celebrano in tutto il loro splendore».
(photo credits: Vincenzo Palazzo Bloise)
Il Corriere di Malta è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale e rimanere sempre aggiornato